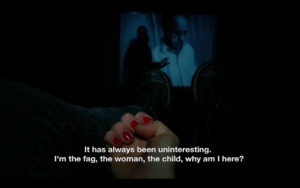di Alessandra Ferlito
“Diversi frammenti dei diari che ho scritto nel corso degli anni, durante i periodi trascorsi nel Bastar, sono stati trascritti digitalmente. Poi sono stati corrotti, convertendo il testo in un mix arbitrario di numeri, alfabeti, simboli, segni di interpunzione e segni diacritici (accenti acuti), insieme ad alfabeti di molte lingue moderne – dall’alfabeto latino, al cirillico a quello greco. Il risultato è profondamente criptico. […] Ancora abbastanza interessanti, i disorganizzati frammenti di trame verbali – ulteriormente spezzettati dalla memoria selettiva del computer, […] conducono narrazioni o spingono a scavare i significati nascosti e crearne di nuovi, in prima istanza imprevisti.”
(Navjot Altaf 2019)
Nel testo che segue troverete delle pagine di approfondimento che potrete aprire cliccandoci sopra;
sono indicate in rosso e grassetto:
vicenda biografica e artistica di Navjot Altaf;
alcune questioni relative al rapporto tra arte e attivismo;
il cortocircuito che mi ha provocato la visione della mostra.
Il Parco Arte Vivente di Torino presenta una mostra intitolata Samakaalik: Earth Democracy and Women’s Liberation – la prima personale in Italia dell’artista e attivista indiana Navjot Altaf. Vado a vederla convinta che mi darà da pensare. Conclusa la visita comincio a prendere qualche nota. Nel frattempo mi trattengo a Torino; le rivolgo occhi e orecchie, la respiro, la tasto timidamente.
La mostra fa parte di un ciclo dedicato ai paesi asiatici, ideato da Marco Scotini – curatore di fama internazionale, teorico e docente che da anni presta attenzione alle molteplici prospettive che, a livello planetario, mettono in discussione l’ordine coloniale e il pensiero egemonico di stampo patriarcale, bianco e occidentale. Dopo avere presentato mostre per me decisamente interessanti, come The White Hunter/Il cacciatore bianco e Il soggetto imprevisto. 1978 Arte e Femminismo in Italia, qui Scotini offre spazio all’intersezionalità. Nel percorso di Altaf, infatti, postcoloniale e femminismo procedono simultaneamente alla lotta di classe e a quella ecologista. Proprio a questa simultaneità di intenti si riferisce il termine hindi Samakaalik. Il resto del titolo parla forte e chiaro: abbiamo a che fare con l’incontro tra questione ecologica/ambientale e femminismo, cioè con l’ecofemminismo. Andando oltre la sintesi estrema di questa etichetta, la mostra mi parla delle possibilità concrete di un cambiamento. Mi fa vedere che delle alternative alle logiche dello sviluppo capitalista possono esistere: in più parti del mondo ci sono “comunità resistenti” che le praticano. Allo stesso tempo, essa dimostra che in questi processi di mutamento, la tecnica e la tecnologia possono avere un ruolo creativo e non-distruttivo, e che l’atto creativo/artistico può avere un ruolo fondamentale e diventare un atto (deleuziano) di resistenza alla morte.
Nel corso di un’intervista rilasciata in occasione dell’evento torinese, Altaf racconta le ragioni del suo impegno politico e sociale attraverso l’arte, affermando, da una parte, che quest’ultima può essere strumentalizzata dalla politica e, dall’altra, che essa è sempre politica. Inoltre, secondo lei, più le attività artistiche risultano inclusive e più le persone possono iniziare a porsi domande e a partecipare attivamente. Partendo da questi assunti, osserverò i metodi della ricerca-attivista che Altaf ha sperimentato negli anni, per interrogare, in seconda battuta, il potenziale discorsivo delle mostre ‘politiche’ nell’attuale contesto culturale-sociale-politico italiano. Se mi dedico a questo esercizio è perché credo che il lavoro di Altaf riesca – simultaneamente – a documentare (voci di minoranze altrimenti silenziate; contraddizioni altrimenti sotterrate), svelare (le menzogne dei discorsi patriarcali dominanti e la violenza del progresso tecnico e tecnologico proposto dal capitalismo) e suggerire (nuove domande, forme di resistenza e auto-determinazione che non escludono il ricorso all’estetica, alla tecnica e tecnologia). In altre parole, perché penso che dalla sua esperienza si possano trarre alcuni spunti preziosi per qualsiasi pratica di lotta che voglia agire in termini anche estetici, per qualsiasi processo creativo che voglia porsi come gesto politico.

Soffermarsi sulla vicenda biografica e artistica di Altaf è interessante per richiamare alcune questioni relative al rapporto tra arte e attivismo: l’utilizzo strumentale dell’arte da parte della politica; lo scarso interesse e riconoscimento, da parte del mondo dell’arte (artisti compresi), nei confronti delle pratiche artistiche fondate sui processi politicamente e socialmente indirizzati; la necessità di rifiutare le posizioni identitarie affrancandosi dai purismi che impediscono la contaminazione; la spinta a sfidare le strategie perverse della cattura capitalista.
La pratica artistica e di attivismo di Altaf ha sempre stimolato una ri-negoziazione costante e costantemente condivisa. Per lei è indispensabile smarcarsi dal ruolo identitario delle etichette, sconfinare tra ambiti e discipline, disfare i linguaggi e le gerarchie. Le questioni appena accennate mi tornano, invece, familiari se penso al contesto italiano, dove il dibattito sulla “politicizzazione dell’estetico” e la “estetizzazione del politico”, da Benjamin in poi, non ha mai smesso di affannare teorici, artisti, storici, critici, curatori. Pure in Italia, la tendenza a non riconoscere il valore estetico-discorsivo di alcune pratiche di attivismo esiste e resiste tra gli ambienti dell’arte ufficiale, dove esse vengono lette per lo più come forme di assistenzialismo sociale o umanitario, o di mediattivismo. In ogni caso, nulla che abbia a che vedere con il fare arte. Allo stesso modo, spesso i movimenti hanno difficoltà a riconoscere la politicità intrinseca di alcune pratiche e ricerche artistiche, che finiscono per essere considerate, nel migliore dei casi, come forme di estetizzazione del politico, oppure peggio, di complicità al regime di rappresentazione; di certo, non come forme di resistenza. Questa fedeltà alle etichette e ai ruoli prescritti, la reciproca miopia e antipatia che essa quasi automaticamente produce, fanno sì che l’incontro tra arte e attivismo non sia poi così frequente; eppure, quando è esistito e quando ancora avviene, esso riesce a produrre esiti imprevisti e non-appropriabili.
Concordo nel pensare che non si tratta di chiedersi “in che modo gli artisti ci possono aiutare a costruire movimento o indicarci nuove strade per fare politica, mettendo a disposizione dei nostri occhi banali e spenti, di cittadini comuni, la loro lungimiranza eccezionale, la loro potenza visionaria, il loro intuito avanguardista” (Revel 2009, p. 56). Credo che dovremmo continuare a guardare l’arte contemporanea come a un’istituzione in cui emergono gli elementi di un governo biopolitico (Baravalle 2009, pp. 12-13). E condivido l’urgenza di mettere in crisi gli spazi e i meccanismi istituzionali della sussunzione, di ri-modularsi collettivamente e costantemente per eludere la cattura di senso e valore, la normalizzazine dei discorsi e delle forme. Per ricordarlo con le parole di Piero Gilardi, artista, attivista e fondatore del PAV, “una narrazione di senso politico è accettata sul mercato. Tuttavia, quando un messaggio politico viene accettato dal mercato significa che è stato neutralizzato attraverso il suo inquadramento nell’estetica. […] ed è proprio questa sovrastruttura estetica ciò che permette a dei messaggi politici di essere commercializzati.”
Proprio le vite artistiche e politiche di Altaf e Gilardi, però, mi suggeriscono più di ogni altra cosa che dovremmo problematizzare l’aut-aut come metodo e interrogarci sulle possibilità che l’incontro tra arte e attivismo ancora oggi potrebbe offrire.

Gli argomenti che propongo risalgono in buona parte a quelli della critica alle istituzioni che dagli anni Sessanta in poi ha riempito, a livello globale, molte pagine, eventi, manifesti politici e culturali. Da quel momento il rapporto tra rappresentanza e rappresentazione è profondamente mutato e “non c’è più l’aspirazione a impadronirsi dello Stato (o dei suoi istituti come il Museo, il Partito, il luogo del Lavoro, etc.), piuttosto […] un’attitudine a difendersi e a uscire da esso […]. “Exit” […] non “Voice”: abbandono anziché scontro. Ricerca di nuovi spazi d’intervento, di immagini costituenti, di micro-azioni su scala locale, di forme di autogestione, di autoorganizzazione, di empowerment.” (Scotini 2009, p. 101). Oggi le condizioni generali sono ulteriormente cambiate e ancor più complicate; il coloniale non è mai morto e ciò di cui abbiamo bisogno sono visioni e pratiche che ci aiutino a resistere alla tossicità dell’antropocene e del capitalocene. Perciò, a maggior ragione, credo che una relazione costante – non-formale e non-gerarchica – tra arte e attivismo, oggi più che mai, vada auspicata e incoraggiata. Lo penso tutte le volte che visito una mostra che si fa vanto dei suoi contenuti sociali o politici ma che allo stesso tempo, per elaborarli, non ha fatto altro che espropriare e inquadrare le soggettività che di quei contenuti diventano forzatamente dei meri oggetti-contenitori (vedi le numerose ‘vittime’ prodotte da certe pratiche “artiviste” o dalle mostre pseudo-antirazziste della sinistra multiculturalista, ancora alla ricerca della “autenticità africana”, o sulla migrazione o sui soggetti socialmente “deboli”). Lo penso quando alcuni spazi dell’attivismo sembrano soffrire di scarsa visionarietà, quella per cui non si riescono a sperimentare forme, modi e linguaggi insoliti, non-previsti, non-catturabili (le esperienze transfemministe e queer fanno quasi sempre eccezione). Soprattutto, lo penso quando mi muovo in contesti più contaminati, dove l’artista e l’attivista non sono più figure sacre o etichette da sfoggiare, ma pratiche e modi indipendenti da ogni vincolo e orpello, che non si definiscono, non si identificano, si mettono in gioco e si lasciano spiazzare dall’imprevedibilità di ogni incontro. Per tornare al dunque, lo penso quando visito mostre come quella di Altaf – anche se fatta per lo più di riproduzioni al posto di opere originali: l’aura dell’unicità è evaporata e si è portata via il pregiudizio dei puri. Le tecnologie digitali e le tecniche hanno dato il loro contributo disintossicante. L’artista ha abbandonato il piedistallo. La dissacrazione è compiuta.
Quale potenziale discorsivo potrebbe, allora, avere una messa in scena della defezione, della disobbedienza, della protesta? (Marco Scotini)
In un saggio del 2009 in cui parla del suo progetto Disobedience – an ongoing videoarchive, Scotini si interroga sul significato della disobbedienza (sociale) e sul senso del mettere in mostra il dissenso. Allo stesso tempo, l’autore individua alcune pratiche e immagini “costituenti”: quelle che rifiutano la rappresentazione verticale del potere in senso classico, a favore di concatenamenti trasversali, multipli, eterogenei, in grado di produrre immagini alternative alle produzioni semiotiche ufficiali e costitutive di una realtà sociale differente. Dalla scrittura di quel saggio sono trascorsi più di dieci anni, durante i quali il curatore ha continuato a disseminare il suo contributo critico prestando attenzione alle esperienze politicamente e socialmente costituenti presenti in Italia (incredibilmente attiva dagli anni Settanta in poi) e nel resto del mondo. Mentre oggi è del tutto irrilevante stabilire se la pratica di Altaf possa definirsi o meno “costituente” o se essa abbia il diritto di entrare nell’archivio delle pratiche disobbedienti, a partire dai contenuti della sua mostra, mi sembra più interessante tornare a chiedersi “se le forme di presentazione di una mostra politica possano sviluppare nuovi modelli di dialogo, ricezione, interazione, critica, azione comunicativa”. È importante capire – continua Scotini – fino a che punto possano forzare i limiti del sapere disciplinato; fino a che punto trasformarlo in un campo di scontro simbolico.

Che significato può assumere e quale potenziale discorsivo può esprimenre il soggetto “resistente” di Altaf, tutt’altro che subalterno, in un paese in cui si fa ancora fatica a riconoscere il proprio passato coloniale; in cui un vero processo di defascistizzazione non si è mai compiuto e l’impronta economica, sociale e culturale è quella capitalista, classista, sessista, razzista, specista? Oppure non è solo una questione di forma, e dovremmo invece interpellare anche la capacità di ascolto, ricezione e analisi da parte del pubblico?
Ad argomentare delle risposte mi aiuta in parte Judith Butler, quando riprende Susan Sontag per parlare di “obbligazione etica”, ovvero della nostra capacità di rispondere a distanza in maniera etica alla sofferenza, e di cosa rende possibile questo incontro etico, quando esso ha luogo:
“[…] ciò che sta accadendo è così lontano da non investirmi di nessuna responsabilità? Oppure, al contrario, ciò che sta accedendo mi è tanto vicino da costringermi a occuparmene? Se non ho causato io, in prima persona, questa sofferenza, vuol dire che non ne sono in alcun modo responsabile? […]”
(Butler, L’alleanza dei corpi, p. 162).
Che tipo di risposta etica può provocare la mostra di Altaf nel suo pubblico? La sua forma di presentazione non è rivoluzionaria, anzi, riprende un modello globalmente consolidato e riconosciuto. Eppure, personalmente, la sua visione mi ha provocato un cortocircuito lento e progressivo, scattato nel momento in cui i suoi contenuti si sono sovrapposti all’attuale situazione politica italiana – quella di governo, da una parte, e quella dei movimenti, dall’altra.
Tornando a Butler: certamente “oggi sappiamo cosa significa sentirsi invasi e sopraffatti da immagini che fanno appello ai nostri sensi; ma lo siamo anche da un punto di vista etico?”. E poiché sappiamo che le immagini sono in grado di sopraffarci e paralizzarci, è possibile, invece, “sentirsi sopraffatti, ma non paralizzati? […] la sopraffazione che subiamo può, in qualche modo, disporci all’azione?” (Idem, pp. 161-64).
La risposta può essere si. A patto, però, che si comprenda che “ciò che accade lì accade anche qui” (Idem, p. 193). Pertanto, anche la domanda di Scotini può avere un esito positivo, ma solo stando alla stessa condizione. Ovvero, una mostra politica come quella di Altaf può sviluppare nuovi modelli di dialogo, ricezione, interazione, critica – può disporci all’azione – indipendentemente dalla sua forma di presentazione, a patto che chi la osserva, completandone il significato, sia capace di stare in ascolto, mettere in dubbio la cultura a cui sente di appartenere, i limiti e i condizionamenti ai quali è soggetta. Solo se chi la riceve è in grado di rallentare, concedersi del tempo, fare 2+2, comprendere che lì e qui non sono poi così distanti; che tra quello che sta succedendo lì e quello che sta succedendo qui ci sono dei nessi profondi – che, a saperli cogliere e analizzare, potrebbero rivelarsi sconcertanti. L’arte, la curatela, l’attivismo, fanno la loro parte. Una mostra – come qualunque essere vivente animato o inanimato, come qualsiasi movimento sociale o politico – ha ragione di esistere solo nella relazione col suo ambiente circostante – animato o inanimato. Ma da sola, cosa può fare?
Per tutte le opere in mostra: Courtesy l’artista
Per il progetto “Nalpar”: Courtesy l’artista e DIAA.
Ringraziamo il PAV per avere concesso l’utilizzo delle immagini.
Dove non indicato diversamente, le foto sono di Alessandra Ferlito.


 “Una donna deve continuamente guardare se stessa”, scriveva John Berger in Modi di vedere (
“Una donna deve continuamente guardare se stessa”, scriveva John Berger in Modi di vedere (
 Facendo zapping fra le diverse serie di cui discute, l’autrice ci ricorda che la genealogia femminista non è leggibile in modo lineare, s’inceppa, si costruisce per interpolazioni e deviazioni, riprese e scarti, in un richiamarsi continuo fra i tempi stratificati della realizzazione, della narrazione e della visione. Da un lato ci sono le serie che presentano un focus più storico-documentario, cioè quelle che raccontano la storia delle conquista dei diritti civili e politici, non sempre facilmente reperibili per il pubblico italiano e di cui Fabbiani offre un’interessante panoramica (persino uno sceneggiato su Anna Kuliscioff prodotto dalla Rai nel 1981, che però si concentra sulle relazioni d’amore della protagonista a discapito della sua attività politica). Dall’altro ci sono serie, pur diversissime tra loro per produzione, genere e ambientazione, da cui emergono tuttavia alcuni temi ricorrenti: il corpo e la sessualità, la famiglia, la maternità, il lavoro, la norma e le differenze, la violenza maschile e quella istituzionale.
Facendo zapping fra le diverse serie di cui discute, l’autrice ci ricorda che la genealogia femminista non è leggibile in modo lineare, s’inceppa, si costruisce per interpolazioni e deviazioni, riprese e scarti, in un richiamarsi continuo fra i tempi stratificati della realizzazione, della narrazione e della visione. Da un lato ci sono le serie che presentano un focus più storico-documentario, cioè quelle che raccontano la storia delle conquista dei diritti civili e politici, non sempre facilmente reperibili per il pubblico italiano e di cui Fabbiani offre un’interessante panoramica (persino uno sceneggiato su Anna Kuliscioff prodotto dalla Rai nel 1981, che però si concentra sulle relazioni d’amore della protagonista a discapito della sua attività politica). Dall’altro ci sono serie, pur diversissime tra loro per produzione, genere e ambientazione, da cui emergono tuttavia alcuni temi ricorrenti: il corpo e la sessualità, la famiglia, la maternità, il lavoro, la norma e le differenze, la violenza maschile e quella istituzionale.