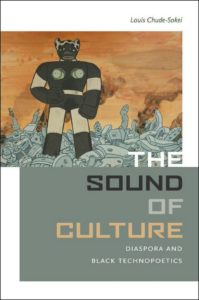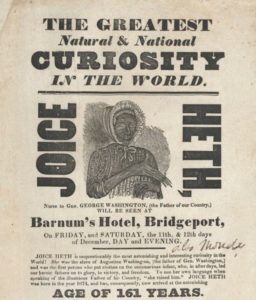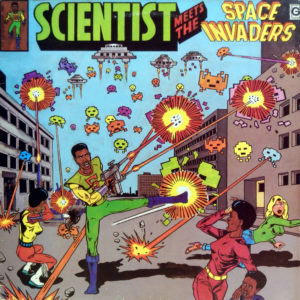La vita è assurda
Lo dice sempre Mike. Nella sua casa su Prinsengracht, nel centro di Amsterdam, si finisce sempre sul divano, a discutere di esistenzialismo, arte, storia, Europa, Brexit, la lingua e l’etimologia. Ogni volta che si alza per versare un bicchiere di whiskey o prendere una lattina di birra fredda sul balcone, Mike chiude o apre una conversazione col suo mantra preferito: la vita è assurda. L’assurdo l’ho incontrato per la prima volta al liceo, leggendo Il Mito di Sisifo e Lo Straniero di Camus. Mi piaceva l’adozione di uno sguardo nichilista sul mondo, perché mi restituiva un senso del reale disilluso e perché mi permetteva di mettere in discussione tutto quello su cui non ero d’accordo: le ore di religione, il modo in cui mi venivano spiegate la storia, la fisica e la matematica. Ero una studentessa allora, e anche oggi, a volte, quando mi siedo sul divano di Mike, mi sembra di essere ancora al liceo, quando provavo a colmare il divario tra la stranezza del mondo e il desiderio di ingabbiarlo in un’unità di senso. L’assurdo rimaneva nello scarto, ciò che non poteva essere completamente conosciuto, l’intraducibile. Più tardi, all’università, ho imparato a fare pace con tutto ciò che è altro dai miei parametri di conoscenza, e quello che prima era assurdo, è diventato poi un modo, tra tanti, di stare al mondo.
Sono appena rientrata da casa di Mike e mi sono seduta a scrivere il mio pezzo per TRU, perché ho visto una mostra che mi ha fatto venire voglia di rimettermi a scrivere di quello che mi piace; sfogliando tra i miei appunti, mentre cerco un filo conduttore per tenere insieme i testi, ecco che mi si palesa ai sensi l’assurdo, il paradosso, la contraddizione.
Odissea nello spazio
Dal 14 gennaio all’11 febbraio, il Melkweg Expo ha ospitato Creating Other Futures, una mostra curata da Brigitte van der Sande, che ha riunito artisti/e e collettivi internazionali attorno al tema del futuro ripensato da una prospettiva non occidentale. L’esposizione è stata parte di un progetto più ampio: Other Futures è una piattaforma online e offline dove teorici/teoriche, artisti/e e produttori/produttrici culturali provenienti da diversi ambiti disciplinari si confrontano con un pubblico di utenti altrettanto variegato per elaborare assieme nuovi visioni del mondo ‘a venire’. Realizzata dalla Mouflon Foundation, in collaborazione con le università di Amsterdam e Rotterdam, e con altri istituti e operatori della scena artistica e culturale locale, la prima edizione del progetto è stata incentrata sulle aspirazioni, come le chiamerebbe Appadurai, evocate dalla fantascienza non occidentale. Oltre alla mostra collettiva, la manifestazione ha incluso un ricco calendario di eventi: un festival di letteratura, musica, cinema e scienza, e una serie di incontri e conferenze accademiche sui temi dell’utopia e del futurismo, intrecciati alle questioni del cambiamento climatico, della razza, del genere e della sessualità nell’odierno contesto politico e socio-culturale.
Per Creating Other Futures, gli/le artisti/e hanno operato un intervento di radicale immaginazione del futuro. Provenienti da diversi background culturali, articolati in linguaggi artistici differenti e radicati in aree geografiche altre dall’Europa e dal resto dell’occidente (Palestina, Kenya, Singapore, Mexico), i lavori si concertano nel rifiuto del futuro così come è già stato consegnato alla storia dalla politica neoliberista dominante: un mondo inteso come insieme ordinato di parti (s-oggetti) separate, la cui relazione reciproca è mediata da poteri economico-politici che decidono della loro inclusione differenziale in questo o quell’altro flusso di produzione e consumo. Disturbi alimentari e la fame nel mondo; ambientalismi e i nuovi colonialismi dell’ingegneria biogenetica; la mobilità degli Expat e il rimpatrio dei migranti. Collocandosi precisamente sul confine dei paradossi del capitalismo contemporaneo, i progetti esposti scardinano ogni assunto della ragione moderna. Gli scenari fantascientifici delle installazioni espongono il pubblico a un esercizio di immaginazione in grado di ripensare le relazioni (sociali, economiche, disciplinari…) tra le parti (non più s-oggetti, ma soggettività) senza quelle fissità astratte prodotte dalla ragione e dalla violenza, parziale o totale, che questa comporta – contro gli altri culturali (non-bianchi/non-Europei) e fisici (non-umani).
 L’artista digitale Jacque Njeri, per esempio, fa dialogare la tradizione del mito Maasai keniota con i tropi afrofuturistici del viaggio nello spazio e della vita su altri pianeti, dando vita a MaaSci, titolo nato dalla fusione delle parole ‘Maasai’ e ‘sci-fi’. L’opera è presentata come una raccolta di stampe grafiche che documentano il viaggio nello spazio della comunità MaaSci. La leggenda, rivisitata dall’artista, narra di una coppia (moglie e marito) che dalla Silicon Savannah parte in esplorazione dello spazio. I due ritorneranno con artefatti provenienti dalla Luna e da altri pianeti, grazie ai quali sarà possibile intrattenere scambi con altre comunità tribali più ricche, così da assicurare ai MaaSci l’approvvigionamento di acqua e risorse alimentari. La memoria del viaggio nello spazio – una narrazione a cui l’artista si riferisce col termine ‘Shestory’ – è appuntata su una pergamena e consegnata alla comunità delle donne MaaSci, depositarie della tecnica e della conoscenza scientifica. Alle donne che, sfidando i costrutti di genere, si dedicano ad occupazioni tradizionalmente maschili, quali lo studio della scienza e dell’ingegneria, si deve infatti la messa a punto delle tecnologie e delle astronavi che continueranno a mandare i MaaSci, nomadi celestiali, nello spazio.
L’artista digitale Jacque Njeri, per esempio, fa dialogare la tradizione del mito Maasai keniota con i tropi afrofuturistici del viaggio nello spazio e della vita su altri pianeti, dando vita a MaaSci, titolo nato dalla fusione delle parole ‘Maasai’ e ‘sci-fi’. L’opera è presentata come una raccolta di stampe grafiche che documentano il viaggio nello spazio della comunità MaaSci. La leggenda, rivisitata dall’artista, narra di una coppia (moglie e marito) che dalla Silicon Savannah parte in esplorazione dello spazio. I due ritorneranno con artefatti provenienti dalla Luna e da altri pianeti, grazie ai quali sarà possibile intrattenere scambi con altre comunità tribali più ricche, così da assicurare ai MaaSci l’approvvigionamento di acqua e risorse alimentari. La memoria del viaggio nello spazio – una narrazione a cui l’artista si riferisce col termine ‘Shestory’ – è appuntata su una pergamena e consegnata alla comunità delle donne MaaSci, depositarie della tecnica e della conoscenza scientifica. Alle donne che, sfidando i costrutti di genere, si dedicano ad occupazioni tradizionalmente maschili, quali lo studio della scienza e dell’ingegneria, si deve infatti la messa a punto delle tecnologie e delle astronavi che continueranno a mandare i MaaSci, nomadi celestiali, nello spazio.

Di passato interstellare tratta anche Windows on the World Part III. Qui, l’artista Ming Wong mette assieme un’installazione video multi-canale che ripercorre e intreccia la storia e le tradizioni della cultura dell’antica Cina in dialogo con il contemporaneo. Gli schermi, sistemati su casse di legno e bancali ammucchiati sul pavimento della galleria, trasmettono scene dell’opera cinese, testi e materiale documentario del programma spaziale del Paese, e sequenze di immagini che documentano un immaginario pop della fantascienza cinese. Questa sorta di scintillante e frammentata futurologia del passato risveglia il corpo e lo spirito di un’esploratrice spaziale, che compare a tratti sugli schermi mentre vaga tra le rovine della storia alla ricerca di una nuova soggettività.

 Il viaggio nello spazio continua per i visitatori della mostra nel lavoro di AiRich. L’artista visuale africana, stabilita ad Amsterdam, introduce il pubblico alla vita sul Pianeta AiRich: una stazione interplanetaria in un’altra galassia, dove i Visionari si incontrano per essere riforniti dal “Grande Tutto” prima di partire per una missione volta al ristabilimento dell’equilibrio e dell’umanità sulla Terra. L’artista espone una documentazione di ritratti e testi che mappano un territorio sconosciuto e invisibile, tanto all’umano quanto alle tecnologie che questo ha prodotto. Armati, avvolti in un campo magnetico che è loro scudo, i Visionari del Pianeta AiRich parlano un’altra lingua, eppure sono in grado di farsi intendere. Il testo, proiettato in loop sullo schermo all’ingresso della galleria, recita: “Ogni attacco a loro sarà restituito indietro, più in fretta della velocità del suono e della luce, e risuonerà nella realtà degli attaccanti.”
Il viaggio nello spazio continua per i visitatori della mostra nel lavoro di AiRich. L’artista visuale africana, stabilita ad Amsterdam, introduce il pubblico alla vita sul Pianeta AiRich: una stazione interplanetaria in un’altra galassia, dove i Visionari si incontrano per essere riforniti dal “Grande Tutto” prima di partire per una missione volta al ristabilimento dell’equilibrio e dell’umanità sulla Terra. L’artista espone una documentazione di ritratti e testi che mappano un territorio sconosciuto e invisibile, tanto all’umano quanto alle tecnologie che questo ha prodotto. Armati, avvolti in un campo magnetico che è loro scudo, i Visionari del Pianeta AiRich parlano un’altra lingua, eppure sono in grado di farsi intendere. Il testo, proiettato in loop sullo schermo all’ingresso della galleria, recita: “Ogni attacco a loro sarà restituito indietro, più in fretta della velocità del suono e della luce, e risuonerà nella realtà degli attaccanti.” Un monito, questo, e un invito a prendere coscienza del fatto che il futuro è preparato in itinere, e non c’è modo di immaginarne un altro libero dal ricordo. “Planet AiRich – si legge ancora sullo schermo – è una stazione di disintossicazione, un rifugio per il rinnovamento”, uno spazio per la pratica della memoria (remembrance) e la cura di coloro che sono (stati) danneggiati.
Un monito, questo, e un invito a prendere coscienza del fatto che il futuro è preparato in itinere, e non c’è modo di immaginarne un altro libero dal ricordo. “Planet AiRich – si legge ancora sullo schermo – è una stazione di disintossicazione, un rifugio per il rinnovamento”, uno spazio per la pratica della memoria (remembrance) e la cura di coloro che sono (stati) danneggiati.

Alimentato forse dall’urgenza di rispondere ai quesiti posti dal dibattito sulla questione ambientale, il tema del futuro mi sembra essere oggi un argomento di grande interesse, a volte anche di tendenza, negli ambienti dell’arte, della scienza e della cultura di consumo in generale, impegnati nella produzione di artefatti che prefigurino un mondo in cui la Terra, la tecnologia, l’umano e l’animale possano co-esistere in maniera sostenibile. Solo che non tutto quello che contemporaneamente si sta producendo in questo senso mi sembra essere inclusivo nei confronti di una differenza che è alla radice di qualunque sistemazione si provi a dare al mondo.

Nel sociale, per esempio, le forze politiche dominanti non mi sembrano in grado di preparare uno spazio di co-esistenza per le diverse soggettività che lo abitano, com’è testimoniato dal ritorno al potere delle destre in gran parte dei governi occidentali, per primo forse l’Italia, dove i discorsi politici dei due partiti vincitori delle ultime elezioni (Lega Nord e Movimento Cinque Stelle) – tra gli altri – si costruiscono su un lessico e una grammatica razziali, in armonia con le politiche di (non)accoglienza adottate da Trump e dall’Europa nei confronti di rifugiati e immigrati. Come spiega Denise Ferreira da Silva in un articolo molto interessante sulla necessità di ripensare la natura e la co-esistenza delle differenze, il programma etico-politico dominante è radicato in una visione dialettica ereditata dal pensiero moderno occidentale, che alimenta sentimenti di incertezza e di paura dell’altro (il terrorista musulmano, l’africano che soffre e muore di fame…).
Altrettanto inadeguate alla complessità del mondo e alla costruzione di un’etica di sostenibilità e co-esistenza della differenza, mi sembrano essere alcune proposte provenienti dalla scienza. In concomitanza con la mostra Creating Other Futures, lo scorso 6 febbraio, i media occidentali hanno puntato i riflettori sul lancio del Falcon Heavy, il razzo studiato per mettere in orbita carichi pesanti per grandi basi orbitanti e per assemblare grosse astronavi, realizzato dagli ingegneri di SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk. Quella sera ho cenato da Simon; verso le dieci lui e Pablo seguivano in diretta il viaggio della capsula, incuriositi e affascinati da una specie di estetica pop futurista: un razzo rilasciava nello spazio una Tesla rossa con un astronauta finto al volante, dotato della tuta sviluppata per gli astronauti veri della Dragon V2 e accompagnato dalle celebri colonne sonore di David Bowie. “Piccolo spazio pubblicità…”, cantava Vasco, in Bollicine, nel 1983. Per la sua nuova impresa interstellare, Musk è stato eletto dalla maggior parte dei media occidentali come indiscutibile icona del futuro. Ma quale? Di chi? Per chi? Per assurdo, il nuovo magnate dell’industria aerospaziale e proprietario della Tesla, compagnia di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari leader nel settore dei trasporti green, celebra la sua impresa nello spazio rilasciando in orbita una macchina, alla faccia delle politiche di sostenibilità ed ecologia di cui la sua azienda si fa promotrice. Non solo. Come sottolineato dallo scrittore e urbanista Paris Max, in un articolo per Jacobin, “le tecnologie di cui abbiamo bisogno per trasformare la nostra rete di trasporto esistono già, ma gli americani sono stati a lungo bloccati in un sistema datato e auto-dipendente mentre gli veniva negata la tecnologia del presente da politici invischiati nella lobby dei combustibili fossili e dipendenti da un’ideologia del “mercato libero”, tanto che crederebbero a qualunque ricco imprenditore che si presentasse loro con una soluzione.” Le proposte di Elon Musk per lo sviluppo delle tecnologie di trasporto sono di fatto disegnate per rallentare la costruzione di un’infrastruttura che potrebbe realmente aggiornare il sistema dei trasporti americano spingendolo, finalmente, nel XXI secolo. Seppur sia possibile riconoscere all’imprenditore il merito di aver dato una spinta all’industria del settore verso lo sviluppo e l’implementazione di veicoli elettrici, la sua visione del futuro della mobilità non si emancipa da una tipologia di trasporto automobilistico individuale, esclusorio ed esclusivista.
Davanti a questi modelli dominanti per gli scenari natural-culturali del futuro, preferisco rivolgermi all’arte, nella cui selva ho trovato proposte di cambiamento molto più radicali, meno glam (forse) e decisamente inclusive, in grado di scardinare gli assunti del pensiero moderno, che ripete da secoli un’aberrante separazione della differenza (di corpi, materie, specie, generi e sessualità). I lavori esposti al Melkweg Expo in occasione della mostra Creating Other Futures, in questo senso, interrompono proprio questa dialettica, attraverso la messa in discussione della dicotomia tra un occidente maschio, bianco e depositario della Storia e della Scienza e il resto del mondo, eternamente colonizzato e cronicamente in ritardo sul progresso, secondo i parametri dello sviluppo e della civilizzazione moderni.
In the Future They Ate From the Finest Porcelain
Se della memoria, intesa come indispensabile e inevitabile punto di partenza per l’immaginazione di altri futuri, trattano i progetti artistici sopra presentati, questa diviene snodo centrale nella trama del film-documentario fantascientico di Larissa Sansour, pure parte della mostra al Melweg Expo. L’artista palestinese, in collaborazione con l’autrice danese Søren Lind, anticipa già nel titolo del suo lavoro l’anacronismo storico: l’interruzione della narrazione dominante del mondo necessaria a qualunque nuova prefigurazione del futuro si intenda produrre. In the Future They Ate From the Finest Porcelain si articola trasversalmente nel dialogo tra fantascienza, politica e archeologia. Combinando live motion e CGI (computer-generated imagery), il film esplora il ruolo del mito per la storia e per la costruzione di un’identità nazionale. Un gruppo di resistenza narrativa scava dei depositi sotterranei destinati alla conservazione di manufatti in porcellana, appartenenti ad una civiltà immaginaria. Lo scopo è quello di influenzare la Storia e sostenere le future rivendicazioni della terra, di cui tale civiltà è (stata) spossessata. Una volta dissotterrate, le ceramiche proveranno l’esistenza di questo popolo, permettendo il riconoscimento della sua identità nazionale. Nel video-saggio, una voce fuori campo rivela la filosofia e le idee alla base delle azioni del gruppo di resistenza: costruendo e mettendo in atto un mito, vale a dire performandolo, è possibile operare un reale intervento nella storia, costruendo di fatto una nazione. “La finzione, l’immaginazione, la letteratura hanno un impatto sulla politica e sulla storia” – recita la voce narrante; “il mito crea i fatti e permette l’identificazione… aggiunge numeri, scombinando l’ordine matematico dei governanti, che impongono una narrazione e si accorgono degli altri solo quando questi si ribellano.” Le sequenze del film si susseguono. Alla voce fuori campo, si aggiunge il dialogo tra la protagonista, leader del movimento di resistenza, e la sua psichiatra: uno scavo nell’inconscio e nella memoria alla ricerca di un futuro remoto, costruito a ritroso, e reso negli scenari di una futurologia del passato, in cui ambientazioni archeologiche e spaziali si sovrappongono.
Appena accanto alla sezione della galleria in cui è proiettato il video-saggio, in delle nicchie ricavate nella parete, due sculture dell’artista palestinese proseguono l’interrogazione del futuro e la sua immaginazione a ritroso. L’installazione scultorea presenta le riproduzioni in bronzo di una piccola bomba nucleare dell’epoca della Guerra Fredda russa. Sul disco di ciascuna delle due capsule sono intagliate le coordinate latitudinali e longitudinali di due depositi di porcellane e ceramiche. Con la porcellana di fatto assente dall’installazione, le bombe rappresentano gli artefatti archeologici in assenza. Le coordinate di ciascun deposito rimandano ad un luogo sul confine israeliano-palestinese, in cui l’artista ha tenuto una performance in collaborazione con istituzioni artistiche locali: durante l’azione, artefatti in ceramica e porcellana, decorati con i pattern della kefiah, il tradizionale copricapo della culture arabe e mediorientali, sono stati interrati in quindici depositi. Delle foto in bianco e nero documentano i luoghi dell’intervento artistico. Archaeology in Absentia interroga il ruolo dell’archeologia e la sua strumentalizzazione come nuova forma di guerra. Le sculture ovali, richiamando la forma delle uova Fabergé, una realizzazione di gioielleria ideata presso la corte dello zar di tutte le Russie ad opera di Peter Carl Fabergé, alludono alla sospensione delle produzioni artistiche contemporanee tra la realtà politica da cui sono influenzate e il loro stato di beni di lusso.

 Archeologia, etimologicamente, vuol dire “discorso delle cose antiche”. Bisogna ricordare giorno per giorno, minuto per minuto, secondo per secondo; sotterrare e dissotterrare miti in accordo con quello che (ci) succede intorno; scombinare l’ordine cronologico del tempo, cambiare i confini alla geografia, i numeri alla matematica, per accorgersi che il futuro non esiste: è una performance. E non sono forse queste – le performance – dei continui riadattamenti della memoria?
Archeologia, etimologicamente, vuol dire “discorso delle cose antiche”. Bisogna ricordare giorno per giorno, minuto per minuto, secondo per secondo; sotterrare e dissotterrare miti in accordo con quello che (ci) succede intorno; scombinare l’ordine cronologico del tempo, cambiare i confini alla geografia, i numeri alla matematica, per accorgersi che il futuro non esiste: è una performance. E non sono forse queste – le performance – dei continui riadattamenti della memoria?