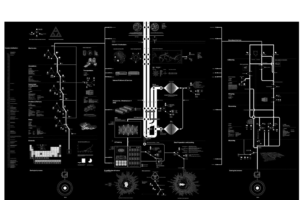versione ridotta dell’Introduzione a Bestiario Haraway. Per un femminismo multispecie, Mimesis 2020, in uscita
Prefigurando un terzo manifesto ancora mai scritto, Haraway ha detto di pensare “per ecologie”[1], inizialmente tripartite fra viventi umani, altri dagli umani e tecnologie, e oggi estese alle n-connessioni fra molteplici componenti organiche e macchiniche dello Chthulucene. La sua riflessione sui confini tra umani e non umani, condotta a partire da una radicale critica dell’umanesimo e approdata al progetto compostista, ha influenzato il campo degli Animal Studies e contribuito in modo determinante alla considerazione della questione animale nel femminismo, coniugando studi della scienza e della tecnologia, scienze naturali e studi culturali.
Due sono gli aspetti, distinti qui soltanto per chiarezza analitica, che Haraway considera quando parla di animali non umani: da una parte la necessità di una radicale re-visione epistemologica, degli strumenti di cui ci serviamo per rappresentarli, fondata sulla co-implicazione fra osservatori, osservati e dispositivi di osservazione e su una visione posizionata che sottrae l’umano al privilegio dell’invisibilità. Dall’altra, le conseguenze che tale re-visione comporta sul piano ontologico, una volta lasciata emergere la non-separabilità simpoietica fra i viventi, e sul piano etico-politico, laddove la re-visione della specie si traduce in ri-spetto e respons-abilità nelle pratiche.
L’idea che gli animali debbano essere rappresentati, non sapendo rappresentarsi da sé, caratterizza un approccio all’ecologia orientalista e imperialista, alla base di discipline come la primatologia e la zoosemiotica e che oggi ritorna, per esempio, in certo conservazionismo come nell’animalismo dei diritti: “ciò che viene rappresentato deve essere disancorato dai nessi discorsivi e non discorsivi che lo circondano e costituiscono e ricollocato nell’autorevole dominio del rappresentante. Di certo l’effetto di questa magica operazione è quello di depotenziare proprio quelle/i […] che sono più prossime/i all’oggetto ‘naturale’ ora rappresentato […] a fondamento di una pratica rappresentativa che autorizza per sempre il ventriloquo a parlare per loro. La tutela sarà eterna. il rappresentato è ridotto allo statuto permanente di destinatario dell’azione, non deve mai diventare co-attore di una pratica sostenuta da compagni sociali diversi e nondimeno capaci di cooperazione”[2].
Nei testi di Haraway, gli animali non luccicano come specchi, non riflettono come schermi, non sottostanno come supporti: sono densi (torbidi persino, stando al lessico di Chthulucene), resistono, evadono, rovinano, e la loro opacità sconfessa quell’eliotropismo abbagliante del pensiero del dominio, patriarcale e occidentale, di cui Haraway rivela le “lesioni retiniche”[3]. L’altermondialità [otherworldliness][4] lascia esistere gli animali fuori dall’essere, poiché non li cattura in una dinamica di inclusione/esclusione: non è sussumibile nella misura dell’umano che li trasforma in antropofori,ma allo stesso tempo non è completamente alterizzabile in quanto differenza naturale, ab-soluta, ossia svincolata dalle relazioni con l’umano.
Nei contesti narrativi, simbolici o allegorici dei bestiari, gli animali assumono più di un significato allo stesso tempo. Le pagine dei bestiari funzionano come uno dei tanti spazi di addomesticamento, insieme a parchi, riserve, zoo, allevamenti, circhi, che appropriano gli animali, siano essi reali, immaginari o a malapena immaginabili, o tutte queste cose insieme. Le ferae ammansite come ciferae[5] riescono però sempre a sottrarsi a una codifica piena e univoca. Nei bestiari medioevali, sono exempla per insegnamenti morali in apologhi edificanti e veicolano dogmi di difficile comprensione nelle predicazioni degli ordini mendicanti; ma in conseguenza di una più ampia diffusione dell’aristotelismo e dei compendi enciclopedici esemplificano anche questioni secolari che riguardano la cultura, l’economia, l’organizzazione della società[6], giungendo a toccare i suoi margini nella forma del mostruoso e del meraviglioso.
Nel Medioevo, scrive Michel Pastoureau, i bestiari non appartengono al campo della storia naturale, ma a quello della storia culturale[7]. Per il “serraglio di figurazioni” animali[8] di Haraway, tuttavia, questa distinzione decade perché gli animali sono attori naturalculturali, agenti sociali a pieno titolo. Se la specie per Haraway è un ossimoro, non può che esserlo anche un bestiario harawaiano, poiché in esso e i recinti si rompono, le tassonomie saltano e le definizioni tracimano, e gli animali non rimangono relegati al ruolo di altri muti, osservati, classificati – dunque appropriati. Haraway non ricorre certamente alla grammatica codificata e catalogatrice del bestiario tradizionale, ma non si limita neppure esclusivamente all’invito al divenire animale, all’accoglimento della forza impersonale di zoe o all’esperienza della irriducibile limitrofia dell’animalità, per quanto certamente accolga, ancora di più negli scritti recenti, una considerazione del vivere trans-soggettivo e un “ispessimento” delle piegature fra i corpi.
Haraway non metaforizza gli animali ma neppure romanticizza il metapherein vitalistico, perché non perde mai di vista la materialità delle associazioni in cui tutti gli animali, umani e non, sono materialmente implicati, come figurazioni[9] incarnate che non si lasciano inchiodare nei luoghi comuni (topoi) del loro rappresentare, ma richiedono di essere, per così dire, “spacchettate” nelle con-figurazioni che compongono più vasti assemblaggi. I grovigli animali harawaiani non fanno mai riferimento alla “interconnessione di tutti gli esseri in un’unità, ma [al]le relazioni materiali specifiche del differenziarsi continuo del mondo”, per usare le parole di Karen Barad[10]. Così, non soltanto le categorie per definire gli animali, a cominciare dall’umano, sono radicalmente sovvertite, ma pure gli studi che li riguardano sono chiamati ad aprire i loro steccati ed essere in grado di percorrere i grovigli tecnoscientifici di un complesso globale dove industria agroalimentare, farmacologia, ricerca militare, biotecnologie, cibernetica, concorrono a formare i nodi materialsemiotici dei corpi animali.
Gli animali non umani sono altri sociali attivamente significanti, non solo significativi per il senso dell’umano, con cui condividiamo una lunga storia di coevoluzione. Impossibili da identificare “a immagine e somiglianza”, con Haraway gli animali escono dalle teche e dagli inventari nei quali erano stati ordinatamente disposti per attraversare gli incroci trafficati del farsi in comune del mondo. Piuttosto che il divenire umano dell’animale o il divenire animale dell’umano, Haraway racconta il divenire-con di animali umani e non umani insieme. Nei suoi testi, incontriamo gli animali in zone di contatto che ci chiamano in causa e dove come specie compagne diventiamo ciò che siamo riconoscendo le nostre relazioni naturalculturali trans-specie.
Le specie compagne, scrive Haraway sono “un bestario di agentività, delle modalità di relazione”[11], progetti di confine e coabitazioni rischiose, che non presuppongono la similitudine o la comunanza in partenza, ma una disponibilità a coltivare alleanze trasversali e tessere ecosistemi, e così “mondeggiare” [worlding], in modi che possono rivelarsi tanto generativi quanto distruttivi, ma non sono più riproduttivi (nel duplice senso di non ricorrere né alla filiazione né alla duplicazione dell’Identico). Mai in sé, sempre con, le specie compagne si riconoscono parziali e aperte e si rendono capaci (respons-abili) a vicenda, e poiché scongiurano il mito dell’origine sono in grado di affrontare anche la propria finitudine. Non si può fare la conta dei morti, dei non morti, dei mai nati, degli scomparsi separando le specie: chi può nascere e chi è costretto a farlo, chi muore o chi è ucciso, chi sopravvive e chi scompare, tout se tient.
[1] D. Haraway in J.J. Willams, Science Stories: An Interview with Donna J. Haraway, in “The Minnesota Review”, nn. 73-74, 2009, p. 155.
[2] D. Haraway, Le promesse dei mostri, tr. it. di A. Balzano, DeriveApprodi, Roma 2020, pp. 88-89.
[3] Ivi, nota 33, p. 51.
[4] Ivi, nota 33, p. 50.
[5] T. Tyler, Ciferae. A Bestiary in Five Fingers, University of Minnesota Press, Minneapolis 2012.
[6] Per esempio, le sirene indicavano la tolleranza verso la prostituzione, mentre alcuni animali rimandavano alle pratiche di caccia o al loro impiego in agricoltura o in medicina. Dal Rinascimento in avanti la rappresentazione di animali sconosciuti, esotici o meravigliosi si accompagnò in misura crescente alla colonizzazione del Nuovo Mondo, e i bestiari divennero veri e propri inventari di conquista (Ibid.). Come nota S. Anderson, gli animali antropofagi manifestano la paura (di genere o etnica) dell’altro, e nonostante già a partire dall’atto di nominazione essi costituiscano un modo per affermare l’autorità dell’uomo occidentale, le scene spesso cruente che rappresentano fanno i conti con il rifiuto degli animali di sottomettersi completamente al suo dominio, restando nell’ambito dell’abietto.
[7] M. Pastoureau, Bestiari del Medioevo, tr. it. di C. Testi, Einaudi, Torino 2012, p. 7.
[8] D. Haraway, Come una foglia, tr. it. di G. Maneri, La Tartaruga, Milano 1999, p. 146.
[9] “they serve to ‘represent what the system had declared off-limits’ without, in turn, attributing a separate
status to it” (Braidotti, 2006, p. 170)
[10] K. Barad, La performatività queer della natura, tr. it. di M. Filippi ed E. Monacelli, in M. Filippi ed E. Monacelli (a cura di) Divenire invertebrati. Dalla Grande Scimmia all’antispecismo viscido, Ombre Corte, Verona 2020, in stampa.
[11] D. Haraway, The Companion Species Manifesto. Dogs, People and Significant Otherness, Prickly Paradigm Press, Chicago 2003, p. 6.



































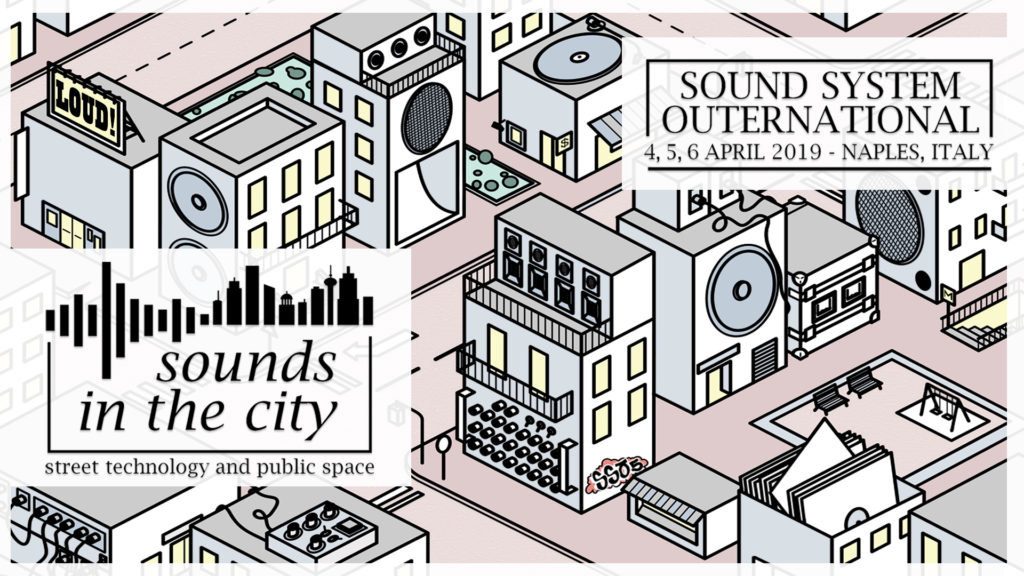






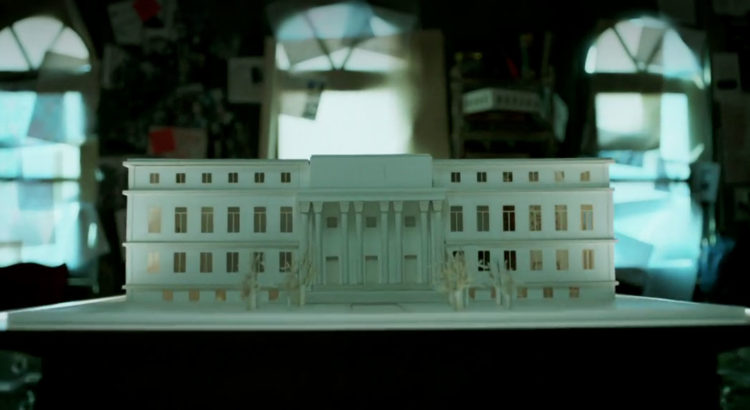

 O almeno è quello che in questo stesso istante lui mi sta dicendo: mi tiene legata al soffitto per i polsi, e mi spiega che anche se il suo algoritmo avrà successo lui avrà perso, perché avrà perso me. Da me, in fondo, un po’ ce lo si poteva aspettare: sono pur sempre ‘una donna’, anche se della polizia. Ma da lui, no. Eppure, il Professore ha smesso di essere una mente infallibile, per diventare un timido cuore pulsante. E a questo punto persino il suo scopo sembra essere cambiato: non più portare a termine il suo piano, ma conquistare me e la mia fiducia. Forse è per questo che mi sta riempiendo la testa con tutte queste sciocchezze: i veri ladri, a quanto pare, non sarebbero loro ma i grandi colossi della finanza, mentre loro stanno semplicemente compiendo un’operazione di giustizia sociale. Figuriamoci… Eppure, dopo che io l’ho scoperto e dopo che lui è riuscito a legarmi, avrebbe semplicemente potuto andarsene, lasciarmi così. Invece sta cercando di convincermi della sua sincerità, e della eroicità del suo algoritmo. Cosa che, con tutte le sue spiegazioni, è quasi riuscito a fare. Proprio per questo tra un istante lo bacerò, anche se solo pochi minuti fa gli ho morso la mano, per vendicarmi del suo inganno. Ma ve l’ho detto, sono molto emotiva…
O almeno è quello che in questo stesso istante lui mi sta dicendo: mi tiene legata al soffitto per i polsi, e mi spiega che anche se il suo algoritmo avrà successo lui avrà perso, perché avrà perso me. Da me, in fondo, un po’ ce lo si poteva aspettare: sono pur sempre ‘una donna’, anche se della polizia. Ma da lui, no. Eppure, il Professore ha smesso di essere una mente infallibile, per diventare un timido cuore pulsante. E a questo punto persino il suo scopo sembra essere cambiato: non più portare a termine il suo piano, ma conquistare me e la mia fiducia. Forse è per questo che mi sta riempiendo la testa con tutte queste sciocchezze: i veri ladri, a quanto pare, non sarebbero loro ma i grandi colossi della finanza, mentre loro stanno semplicemente compiendo un’operazione di giustizia sociale. Figuriamoci… Eppure, dopo che io l’ho scoperto e dopo che lui è riuscito a legarmi, avrebbe semplicemente potuto andarsene, lasciarmi così. Invece sta cercando di convincermi della sua sincerità, e della eroicità del suo algoritmo. Cosa che, con tutte le sue spiegazioni, è quasi riuscito a fare. Proprio per questo tra un istante lo bacerò, anche se solo pochi minuti fa gli ho morso la mano, per vendicarmi del suo inganno. Ma ve l’ho detto, sono molto emotiva…