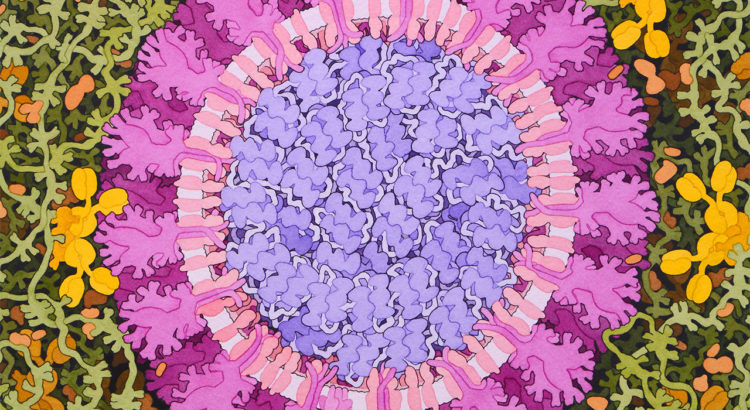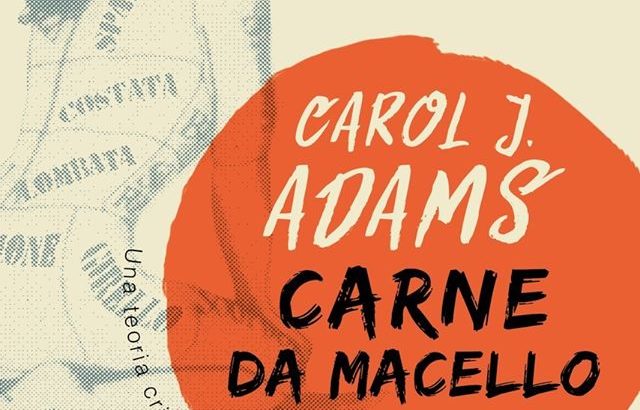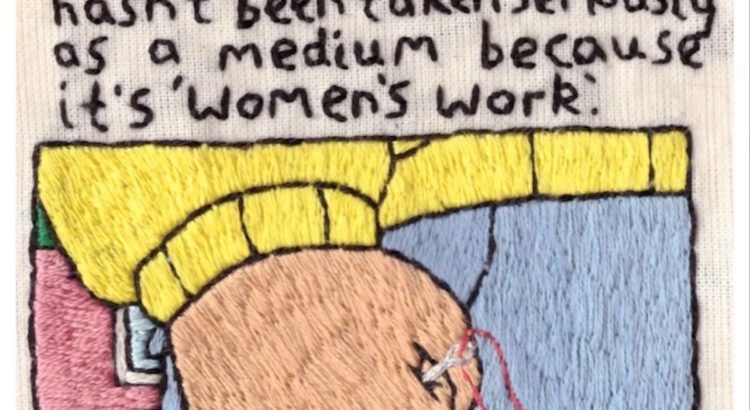Author: Motoko Kusanagi

Il lavoro dei dati non finisce mai
Anne Boyer, poetessa, scrittrice di favole e saggista statunitense, vive a Kansas City, Missouri, dove insegna scrittura al Kansas City Art Institute. Nel 2018 ha vinto il Cy Twombly Award for Poetry e il Whiting Award in Nonfiction/Poetry. La maggior parte dei suoi testi apparsi anche online – molti dei quali disponibili sul suo sito – è raccolta nel volume A Handbook of Disappointed Fate (2018). Della sua principale raccolta di poesie, Garments Against Women (2015), è stato scritto che “ricostruisce la dimensione sociale della sofferenza individuale [e] [o]ffre una prospettiva che interrompe il torpore generato da uno spietato sistema di sfruttamento dandoci la possibilità di capire la natura strutturale dei problemi personali. Possiamo leggere questi piccoli frammenti di vita quotidiana come qualcosa che sta fra teoria e memoir, poesia e informazione”. Nel 2014, dopo anni di ristrettezze economiche e un continuo ammalarsi per le difficoltà del vivere ordinario, quando da qualche anno ha ottenuto un lavoro a tempo indeterminato, le viene diagnosticato un tumore maligno al seno. Boyer inizia allora a intrecciare la scrittura sul corpo malato e sulle pratiche di cura alle riflessioni sul lavoro, sul dolore, sulla vulnerabilità e la solitudine, e sul tempo delle parole e quelle del silenzio. Oltre al sito, si possono leggere le note di Boyer sulla newsletter-diario Mirabilary, nel quale su descrive così: “sono una comunista e lo sono sempre stata, e questo vuol dire che so che il mondo è e dovrebbe essere per tutte le persone che lo abitano. Il mio amico Anhony mi ha mandato una foto del suo gatto via messaggio intitolandola “si è addormentato lottando”. E è questo l’obbiettivo”. Il prossimo Autunno è prevista l’uscita di The Undying, un libro sul vissuto della malattia e della disabilità che questa comporta, presente anche nelle riflessioni del saggio qui proposto, che affronta in particolare il contrasto tra l’esperienza incarnata della malattia e l’astrazione dei corpi della medicina, la “simultaneità paradossale” fra lavoro di cura e lavoro dei dati, ma anche le differenze dei corpi al lavoro.
“Il lavoro dei dati non finisce mai” è apparso in lingua originale sul magazine Guernica nel 2015, ed è qui riproposto nella traduzione italiana di feminoska per Les Bitches (2018). Lo ripubblichiamo qui come parte del nostro piccolo speciale sulla Social Reproduction Theory nel femminismo contemporeaneo e come contributo allo sciopero globale transfemminista di domani: #lottomarzo
Nelle sale d’aspetto delle cliniche oncologiche, il lavoro di cura è inseparabile dal lavoro dei dati. Le mogli compilano i moduli dei mariti, le madri quelli dei figli*. Le donne malate riempiono i propri. Io sono malata e donna, quindi scrivo il mio nome. Ad ogni appuntamento mi viene consegnato un foglio stampato dal database generale, che devo correggere o approvare. Le banche dati sarebbero vuote senza di noi. Il lavoro di trasformazione di una persona in paziente è un lavoro femminile – solo ad uno sguardo superficiale può sembrare un lavoro svolto da macchine.
Le addette alla reception distribuiscono i moduli e stampano i braccialetti, che verranno poi letti da scanner stretti dalle mani di altre donne. Le infermiere si affacciano a porte dalle quali non emergono mai del tutto e che tengono aperte col proprio corpo, chiamando i pazienti per nome. Queste donne sono i parà delle soglie: pesano i corpi dei pazienti su bilance digitali e misurano i segni vitali negli anfratti del reparto accettazione della clinica.
Poi accompagnano il paziente – nel mio caso, mi accompagnano – alla sala visite, e si collegano al sistema. Inseriscono i numeri generati dal mio corpo, che si offre alle macchine: quanto sono calda o fredda, la velocità con cui mi batte cuore. Poi mi chiedono: In una scala da 1 a 10, come valuta il suo dolore?
Provo a rispondere, ma la risposta corretta è sempre “a-numerica”. Le sensazioni sono nemiche della quantificazione, e non esiste (ancora) una macchina alla quale il sistema nervoso possa comunicarle in misura sufficientemente descrittiva.
La malattia è caotica. La medicina sovra-risponde all’evento indisciplinato che è la malattia del corpo trasmutandolo in dati. Il paziente diventa informazione, non solo in base alla quantità di ciò che produce o attraversa il suo corpo singolo: i corpi e le sensazioni di intere popolazioni vengono convertite nella matematica della probabilità – di ammalarsi o stare bene, di vivere o morire, di guarire o soffrire – su cui si basa il trattamento. Tutti i corpi sono soggetti a questi calcoli, ma sono corpi di donna, il più delle volte, a svolgere il lavoro preliminare di trasformare la nebulosità e l’incalcolabilità della malattia nella matematica tecnologicamente avanzata della medicina.
Nome e data di nascita. Il nome di una malata di cancro, come da lei stessa confermato, è aggiunto al codice a barre del suo braccialetto, ed a qualsiasi sostanza – fiale di sangue prelevato, farmaci chemioterapici da infonderle – la cui posizione e identità debbano essere verificate. Anche se il braccialetto è già stato scansionato per accertare la mia identità, chiedermi di ripetere il nome è il piano di riserva delle informazioni mediche: è il punto di ogni trasmissione di qualcosa da o verso il mio corpo. A tratti potrei ricordare chi sono, ma la ripetizione è un metodo di desensibilizzazione. Valutarsi in una scala da 1 a 10? Nell’astrazione intensiva e medicalizzata del cancro, esisto a malapena, la mia persona diventa un mero accessorio delle sensazioni del corpo e dei sistemi informatici della medicina.
Incontro le infermiere nella sala visite, dopo aver indossato un camice al posto dei vestiti. Si collegano al sistema. A volte mi hanno già fatto un prelievo di sangue, e mi viene permesso di leggere una pagina stampata che ne riporta le componenti. Ogni settimana il sangue trasporta quantità variabili di cellule e altre sostanze rispetto alla settimana precedente. I livelli di queste sostanze aumentano o diminuiscono, determinando la quantità e la durata dei prossimi trattamenti. Le infermiere mi interrogano sulle percezioni che provengono dal mio corpo e inseriscono le mie sensazioni in un computer, cliccando sui sintomi – a cui è stata assegnata da tempo una categoria, un nome e un codice assicurativo.
La parola cura raramente richiama alla mente una tastiera. Il lavoro, spesso non retribuito o mal pagato, di coloro che prestano cura (a volte chiamato “lavoro riproduttivo”, ovvero la riproduzione quotidiana di se e degli altri come corpi viventi, l’alimentazione, la pulizia, la cura e così via) è ciò che la maggior parte delle persone definirebbe come il meno tecnologico, il più affettivo e intuitivo. La cura è spesso intesa come un modo di sentire, vicina come è all’amore. La cura appare così distante dalla quantificazione, come le sensazioni di fragilità o dolore della persona assistita sono assenti dalle statistiche. “Mi prendo cura di te” suggerisce una diversa modalità di astrazione (quella del sentimento) rispetto alla misurazione del tasso di divisione cellulare di un tumore (quella del fatto patologico). Ma nel corso di una malattia grave si verificano strani capovolgimenti. O meglio, ciò che sembra essere un capovolgimento diventa un chiarimento. I nostri corpi animali, un tempo solidi, imprevedibili, sensibili e incredibilmente disordinati, soccombono – imperfettamente, ma intensamente – alle condizioni astratte della medicina. La cura diventa concreta e materiale.
Segretarie, assistenti, tecniche di laboratorio e infermiere non devono solo inserire le informazioni provenienti dal mio corpo nei database, ma anche prendersi cura di me mentre lo fanno. In ospedale, la mia urina è analizzata e valutata dalla stessa persona che mi tiene compagnia chiacchierando amabilmente. In tal modo, le procedure dolorose si fanno meno dolorose. Le lavoratrici che controllano il mio nome due volte, scansionano il mio braccialetto ed eseguono con accuratezza la doppia procedura di controllo mentre mi attaccano all’infusore dei farmaci chemioterapici, sono le stesse che mi toccano con delicatezza il braccio quando ho paura. L’infermiera che mi fa il prelievo di sangue, mi racconta una barzelletta.
Il lavoro di cura e il lavoro dei dati esistono in una sorta di simultaneità paradossale: ciò che entrambi hanno in comune è che spesso sono compito delle donne e, come tutto ciò che è stato storicamente definito come lavoro femminile, è un lavoro che appare invisibile. Spesso viene notato solo quando è assente: una casa sporca si nota di più di una pulita. Lo sfondo che sembra esistere senza sforzo si materializza con enorme fatica: il lavoro di cura e il lavoro dei dati sono silenziosi, quotidiani, continui e infiniti. Il file di un paziente è, come una casa vissuta, un luogo di lavoro che dura per l’eternità umana.
Nel corso del mio trattamento contro il cancro, tutte queste lavoratrici – addette alla reception, paramedici e infermiere – sono state donne. I dottori, a volte donne e altre volte uomini, mi incontrano nell’istante di massima quantificazione del mio corpo. Accedono al sistema, ma digitano meno e, a volte, non lo fanno affatto. Mentre con gli occhi scorrono lo schermo, che mostra le categorie e le quantità aggiornate del mio corpo, penso alle Devozioni Per Occasioni Di Emergenza di John Donne: “Mi hanno visto e ascoltato, immobilizzato e raccolto prove: ho reciso la mia stessa anatomia, mi sono sezionato e ne hanno ricavato informazioni.”
Se le donne sono coloro che trasmutano i corpi in dati, i medici sono gli scanner. Non praticano alchimie eccezionali. Altre lavoratrici mi hanno sublimato ed etichettato: ho informatizzato le mie sensazioni. Sono i dottori che mi leggono, o meglio, leggono ciò che il mio corpo è diventato: un paziente fatto di informazioni, prodotto dal lavoro delle donne.