(riflessioni e immagini dal e sul progetto di Alessandra Cianelli Making a baby_Liquidliferecallingplace_See@flower 0.0“, 2006-2011 )
Parto da molto lontano e intreccio aspetti ed esperienze disparate della mia biografia e della mia pratica artistica e di riflessione critica, per parlare di violenza di genere guardando a un aspetto/qualità/facoltà peculiare della dimensione femminile, ovvero “fare bambini”.
La riflessione si espande prendendo in considerazione, come forma sottile e pervadente di violenza di genere, il controllo culturale e sociale, consapevolmente o inconsapevolmente esercitato o subito, attraverso il sistema sanitario ed economico stabilitosi intorno alla “riproduzione/ produzione” di prole. Già agli albori della modernità i processi di accumulo del capitale nascente e la necessità del controllo produttivo, hanno iniziato a impossessarsi, piano piano dei corpi e delle anime, allo scopo di legarli sempre più alla catena di montaggio. Il fare/avere bambini e/o essere madre come lavoro riproduttivo femminile, nel tempo sempre più orientato ad essere produzione di prole/figli per il proletariato, presenta oggi, in particolare con la crescente medicalizzazione, alcuni aspetti inquietanti come processo di acquisizione di status/bene di consumo.
La complessità dell’intreccio tra la mia biografia, la pratica artistica e le riflessioni critiche, richiede di essere illuminato a partire dalla suggestione della figura potente ed evocativa di un’antica prozia, antenata recente (che lega tra l’altro me a Emanuela Sica, curatrice di questo volume).
Si chiamava Zia Maritana, sorella del bisnonno materno e madre adottiva di mia nonna, di cui posseggo solo poche parole di racconti in frammenti, ma sospesi quanto basta nella luminosità soffusa della visione. “Zia Maritana guariva il mal di pancia dei bambini, cantando con gesti misteriosi, filastrocche antiche.” Tenuta in grande considerazione come guaritrice del corpo e dell’anima era anche la scrivana per i contadini analfabeti del paese, che, in cambio, portavano preziosi doni, in forma di cibo, polli, uova, formaggi. Zia Maritana, che non aveva figli, soprattutto faceva nascere i bambini. Quello era un tempo, fino agli anni 60 del nostro secolo, in cui la procreazione e l’assistenza alla procreazione era arte della levatrice, ambito speciale delle donne, sensibilità creativa al servizio della più specifica, ma non la sola, potenza creatrice di una creatura mammifera di sesso femminile. A quel tempo, recente, lontano dalle città, era possibile incontrare capsule spazio-temporali in cui la medicina, arte del tenere in equilibrio la salute del corpo, della mente e dell’anima non era ancora del tutto disciplina culturalmente maschile. Soprattutto nell’ambito del fare bambini era arte femminile in una maniera peculiare, intanto proprio perchè arte, piuttosto che scienza. Chi esercitava quell’arte ereditava conoscenze fatte di esperienze antiche di secoli, nutrite dalla profondità del tempo, quasi ancora fuori dalla linearità spazio-temporale, scientifica cartesiana, illuministica teleologica, patriarcale.
Gli antichi saggi affermavano che i semi di sette generazioni sono addormentati nella profondità di ciascun individuo. Questi semi possono risalire e germogliare oppure non germogliare e rimanere dormienti, passando alle generazioni successive, a seconda del contesto esterno e interno in cui si ritrovano. La bellissima visione di questi antichi semi dormienti mi aiuta a connettere parentele, eredità sottili ed esperienze personali che sono state spunto di una ricerca artistica iniziata tanto tempo fa, con un video del 2004, poi evolutasi fino a diventare il progetto Memoriale della vita liquida /Liquid life Recalling place, un lavoro installativo e performativo presentato per la prima volta nel 2010. Il primo video del 2004 Bambini d’acqua – Bambini di Sapone, nato come una riflessione personale sull’aborto, sui non ancora nati o mai nati, sulla vita prenatale, interrogava la relazione tra la gravidanza e il corpo femminile gravido, ovvero portatore di un carico, che è anche una pienezza, pregnanza, come evoca l’inglese pregnancy, e i processi e pratiche, culturali, sociali e di cura, legati alla riproduzione e alla produzione. A quel tempo ho scoperto dell’esistenza di un rito in Giappone, il cui nome significa letteralmente ‘Rito per i bambini d’acqua’,Mizuko kuyo’, un complesso di riti e cerimonie moderne di ‘riparazione’ dell’aborto.
Una volta l’anno (ma esistono moltissime varianti della rito) le donne che si sono sottoposte a questa pratica si recano in un tempio o in uno dei cimiteri dei Mizuko-bambini d’acqua, in origine collocati in templi buddisti, dove lo spirito benevolo de Jizo Bodhisattva si materializza in una grande statua o in una impressionante moltitudine di statuine, che proteggono le anime dei bambini mai nati, e a cui le mamme mancate portano doni infantili.
Il rito moderno pare si affermi negli anni ’70, in concomitanza con l’aumento della pressione sociale sulle donne per incentivare la pratica dell’aborto, con conseguente danno al tradizionale ruolo di riproduzione e cura domestica delle donne in Giappone, a cui secondo alcuni studiosi la pratica del Mizuko Kuio offre appunto riparazione.
Seguendo un percorso insidioso tra biologia e biografia, cultura ed economia, società e politica il tema dell’aborto o mancata maternità per aborto spontaneo e la conseguente mancanza (di figli) sul piano sociale e identitario, è emersa una domanda chiave seguita da un sciame guizzante di altre piccole domande.
Che cosa è un bambino? Un appena nato, un non ancora nato, un non più, mai nato?
Cosa significa “fare un bambino” (oggi e/o sempre) e quali sono le ”nostre” idee, visioni e costruzioni culturali, di noi, come esseri di genere femminili e come esseri umani, abitanti e/o native/i, di questa metà del mondo, rappresentata sempre in alto nelle mappe geografiche, ricca, evoluta e figlia scientifica della ragione illuminista?
Ci insegnano, da tempi immemorabili che siamo fatte per fare bambini e che il nostro corpo mammifero femminile è fatto per essere gravido, il che è una verità. E ci insegnano anche, da tempi molto più recenti, che anche la nostra mente e il nostro cuore sono fatti per procreare, ovvero per riprodurre, come produzione e anche come definitivo assoluto atto creativo espresso dal genere femminile.
Così il bambino nato è una possibilità attuata, e il bambino non nato è una possibilità non attuata, una mancanza, per la quale oggi non abbiamo strumenti, nessun rito, nessuna cerimonia di riparazione, di perdono, di pacificazione.
La nebbia densa e persistente fatta di queste idee e di queste visioni, raramente squarciata da un’apertura illuminante, ci ha smarrito, nascondendo quello che sapevamo, nella profondità straordinaria dell’intelligenza e della memoria con/del corpo, che ci accompagnava nella nascita e nella non nascita, con la cura collettiva fatta di ricette, suoni, visioni, filastrocche e ninnananne.
Sapevamo che un embrione è un seme, un germoglio nascosto, appena spuntato. Un seme può nascere o non nascere; è un’intuizione; è vita e non vita.
Il feto, anfibio animale non ancora umano, immerso nell’acqua, protetto e nutrito dalla placenta, nell’oscurità soffice de

ll’utero, è una vibrazione, un battito senza suono, una scintilla nel buio, una promessa, che deve essere necessariamente senza aspettative.
Nella condizione amniotica, il feto è lo stato fluido, cosciente come è cosciente tutta la materia, capace di prendere tutte le forme o nessuna forma.
Liquido, silenzioso, scuro, ricco, autosufficiente e vitale, come l’acqua del mare, nostra umana animale placenta mai abbastanza compianta, il feto è un condizionale, un potenziale indifferenziato, una sospensione, un equilibrismo incerto tra quello che esiste è quello che non esiste o non esiste ancora. Prima della comparsa rassicurante della forma nominabile e visibile, prima della linearità confortante del tempo esterno, prima persino della certezza di essere uno o due.
C’è paura quando si è incinta, dall’inizio alla fine, in quel sentire farsi due, nell’incognita di ritrovarsi o forse non ritrovarsi raddoppiata, moltiplicata, magari spaccata, in un altro da sé che è parte di se, ma separato. Con la gravidanza, il parto o l’interruzione della gravidanza volontaria o involontaria, risale la paura, nella sua più antica forma animale e nelle relativamente giovani angosce culturali.
C’è paura nella responsabilità di quel carico, del dolce peso che ci fa gravide e pregnanti, e c’è paura con l’apertura spropositata che si dispiega inevitabilmente al cospetto della meraviglia di una vita che cresce, si sdoppia e si raddoppia dentro di sé e malgrado sé. E c’è paura nel cambiamento che si sperimenta giorno dopo giorno, nella paura di essere fragili e vulnerabili che sempre si accompagna all’essere aperte di fronte all’ incommensurabile, anche se si è ripetuto più volte il processo, anche se si è visto e accompagnato con altre il percorso.
E c’è molta più paura adesso, che non ci sono più le streghe e le fate a raccontarci la favola di cosa succede, cullando l’ansia e l’incertezza del cambiamento con incantesimi di fiori, erbe e parole, al ritmo di ninna nanne protettive, che medicano anima e corpo.
Si può ricorrere all’arte collettiva di curare e gestire queste paure, stando in e seguendo il processo creativo, o ci si può consegnare, mente, anima e corpo al sapere imperativo del numeri e delle quantità, attraverso la scienza medica.
La mia ricerca intanto, iniziata con il video del 2004, Bambini d’acqua – Bambini di Sapone è approdata nel 2010 al lavoro Memoriale della vita liquida/ Liquid life Recalling place, arricchita da nuovi sguardi e altre attrezzature ricevute in cambio del mio vivere e sperimentare la vita.
Tre giorni di ricerca involontaria sul campo, in un reparto maternità dove ribollivano, mescolati indifferentemente, anime, menti e corpi gioiosi o dolenti.
Una sospensione del tempo, appesa all’orologio dei farmaci, alla decisione o alla comparsa del dottore, alla comunicazione certa della data del parto o dell’aborto, perché lì si disegnava il bordo tra il nascere e il mai nascere, tra il parto, la consegna al mondo e l’aborto, voluto, ma non per questo meno doloroso, o non voluto, spontaneo, come si dice e come era il mio caso.
Tre giorni tutti legati da una linea del tempo, che avvolgeva tutto e tutte, tanto estranea al corpo e all’anima quanto congeniale alle procedure protocollari. Linea insensibile all’unicità individuale e indifferente alla dipendenza emotiva dalla parola, alta, autorevole, definitiva e sempre ‘maschile’, al di là del genere, del “dottore”. Cura affidata alle cure di personale medico per lo più addestrato all’impersonalità deinumeri e delle quantità, all’idea della riproduzione come produzione.
Dall’alto di quel sapere sterile, inevitabilmente patriarcale, si usava evidentemente la paura, invece di cullarla, come mezzo e fine del regime di controllo di tutti quei corpi femminili, interessati dallo stesso stato di gravidanza, eventualmente trasformato in stato di non-salute e perciò oggetto obbligato della disciplina medica.
In quel reparto maternità, non del tutto consapevole (forse) campo di sperimentazione bio-politica, le attività e le funzioni responsabili di gioia, dolore, tenerezza e amore scomparivano, nella pretenziosa chiarezza degli strumenti e dei modelli scientifici, inadeguati però a cogliere quello che non si può misurare e non si può vedere con gli occhi. Le sottili connessioni bio-chimiche e neuronali, che testimoniano imperituri legami tra umori del corpo e umori dello spirito, tra latte e sangue, sudore e lacrime, per lo più semplicemente non esistevano.
Quando parlo in questi termini, salvo comunque non poche singole figure professionali, capaci di operare all’interno di quella cultura e di quell’idea di disciplina medica della saluta del corpo, facendosi portatori di valori altri nel rapporto di cura.
Il processo di spossessamento, iniziato dall’abiura e dalla separazione del corpo dalle dimensioni della mente, dell’anima e del cuore, è giunto ora ad estremi particolarmente sensibili ed evidenti nell’idea e nella cultura del corpo femminile.
Perciò la dimensione femminile, signora del potere di riprodur-si e matrice di un altro tempo, paurosamente ribelle al numero e poca consona al tempo e alla forza del capitale ha visto ridurrenel tempo, non senza complicità, il ‘fare un bambino/non fare un bambino’ a questione di beni di consumo e status.
La tremenda forza creativa della riproduzione, con la medicalizzazione/commercializzazione crescente (parti programmati, inseminazione artificiale, procreazione assistita, maternità surrogata) è (o si è) ora consegnata al discorso dell’”essere/non essere madre/dover essere madre/ avere/non avere figli“.
Lentamente la medicina, arte della cura della vita è diventata scienza della malattia e la gravidanza, stato interessante, si è trasformato da apice della forza creativa a dimensione di malattia, perciò oggetto e soggetto della scienza medica. Partorire, di fatto atto ed espressione di massima forza è diventato momento della fragilità del corpo più bisognosa, inscritto nell’ambito della non efficienza della disfunzionalità, dello squilibrio.
Fare un bambino. Memoriale della vita liquida/ Liquid life Recalling place, il lavoro installativo del 2010, chiudeva il percorso di riflessione intorno al fare o non fare un bambino con la visione dell’acqua e della materia fluida, mezzo e sorgente di ogni creatività, capace di legare e sciogliere il come focus concettuale e materiale del progetto.
Ho sentito o visto, il luogo/status/tempo della vita liquida, ancora senza forma e tuttavia capace di tutte le forme, come naturale memorial di tutto quello che è, che non è, che potrebbe essere.
Da questo luogo liquido si possono richiamare, rimemorare, perciò memorial, le nostre possibilità, le nostre potenzialità, le paura e la meraviglie, di quello che non conosciamo e non possiamo conoscere, se non attraversandolo con il farne esperienza. Questo è il luogo e il tempo senza tempo, nascosto nella profondità di ciascun individuo, dove dormono, senza aspettative, i semi di sette generazioni, in attesa di risalire e germogliare oppure non germogliare e rimanere dormienti.
Al tempo di zia Maritana, fare un bambino era un fare creativo-riproduttivo, certo anche produttivo, ma non ancora del tutto legato alla catena di montaggio.
Nascere e morire erano inscritti nella vita ed erano parte del sapere e della capacità di curare la vita.
A quell’epoca, ancora non lontana, tutte conoscevano lo straordinario potere del corpo femminile custode della potenza di quell’energia creativa che cura, trasforma e attua; tutte praticavano e trasmettevano ancora quei saperi che si erano addensati lentamente lungo un tempo incredibilmente profondo.
Questa conoscenza, vera e unica ricchezza delle madri e preziosissime eredità delle figlie, era parte dell’arte di zia Maritana, che forse da qualche parte dorme, seme nascosto, dentro di me, dentro di noi, in attesa di essere risvegliata.
Perciò qui, dal mio personale memoriale della vita liquida, richiamo quella conoscenza e quella consapevolezza, che può incantare, cullare e calmare il demone naturale della paura, che diventa altrimenti complice di quelle forme di controllo e sfruttamento (a volte autocontrollo e auto sfruttamento) della ri-produzione che è tra le più subdole, ininterrotte e sottili violenze di genere.
A quel tempo di zia Maritana, tempo non lontano nel tempo, ma solo un altro tempo, sempre possibile, il tempo e lo spazio erano ancora un respiro e non una linea.


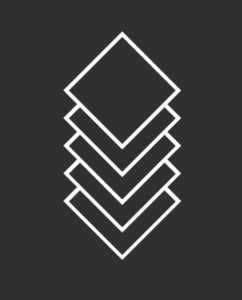


 Una interrogazione sul senso dell’archivio è in senso più vasto e più sottile un discorso sulla memoria. Iniziamo dalla pratica artistica con l’intento di irrompere, provocare o evocare l’Archivio, non solo di raccogliere e mettere insieme memorie e memorabilia, per tentare di eluderne la natura mortuaria e monumentale. Il digitale, la rete, la dimensione 2.0, hanno facilitato l’emersione e l’accesso potenziale a un numero illimitato di archivi, ma ogni singolo frammento di questo ARCHIVIO venuto alla luce è condannato, potenzialmente, contestualmente a scomparire nell’oblio della rete.
Una interrogazione sul senso dell’archivio è in senso più vasto e più sottile un discorso sulla memoria. Iniziamo dalla pratica artistica con l’intento di irrompere, provocare o evocare l’Archivio, non solo di raccogliere e mettere insieme memorie e memorabilia, per tentare di eluderne la natura mortuaria e monumentale. Il digitale, la rete, la dimensione 2.0, hanno facilitato l’emersione e l’accesso potenziale a un numero illimitato di archivi, ma ogni singolo frammento di questo ARCHIVIO venuto alla luce è condannato, potenzialmente, contestualmente a scomparire nell’oblio della rete.

